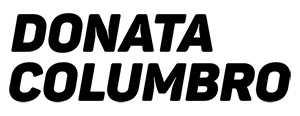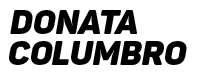Le comunità e il coinvolgimento: i segni per capire se lo stai facendo bene
Alla decima edizione del festival di giornalismo di Perugia almeno quattro panel hanno affrontato il tema dell’engagement e della community dei lettori. Finalmente, a dodici anni dalla definizione pubblica di Web 2.0, chi è sempre stato dalla parte di chi produceva le informazioni si accorge che “il pubblico” non è più solo spettatore. Crea contenuti ma soprattutto cerca e costruisce relazioni con chi ha gli stessi interessi e bisogni.
Il community engagement si può fare a diversi livelli: ognuno presuppone un certo interesse e un investimento di tempo e risorse — persone e soldi — per curare il rapporto con il lettore.
- Il primo livello è quello della moderazione dei commenti nel sito e negli spazi dei social media gestiti dal giornale: lo spazio è curato e tutti sono invitati a tenerlo intatto con regole e intervento di moderatori, che nel migliore dei casi sono i giornalisti stessi.
- Da parte del giornale c’è l’invito a produrre e inviare user generated content in occasione di eventi, progetti specifici, inchieste. Il sito di ProPublica ha una sezione “Get Involved” dove propone diversi modi ai lettori, ai cittadini, di interagire con i giornalisti anche durante lo svolgimento di lunghe inchieste (ultima quella sui tirocini negli Stati Uniti).
- La creazione di spazi di discussione specifici, fuori o dentro il sito del giornale.
Tre sono gli indizi per capire se la tua redazione il community engagement lo sta facendo male:
- Considera engagement solo il ritorno dei lettori sul sito, analizzando il loro comportamento come consumo di notizie attraverso piattaforme di analisi di metriche come Chartbeat e Google Analytics.
- Non modera i commenti al sito, alla pagina Facebook, o, se lo fa, non ha un piano strategico per promuovere commenti virtuosi e riconoscere il valore del contributo dei lettori.
- Non prevede fasi di ascolto con strumenti specifici per capire chi c’è la fuori, cosa fa, quali sono i suoi bisogni, come si organizza per soddisfarli e come il lavoro giornalistico può aiutarlo.
The best opportunity a project like @coralproject gives newsrooms is time to find leads on stories that'd otherwise go unreported. #ijf16
— Jacqui Maher (@jacqui) April 8, 2016
Chi fa bene community engagement, invece, si muove come ad esempio come il Washington Post, dove Greg Barber, direttore del Digital News Lab, è anche il cofondatore di una piattaforma open source per la creazione di community, il Coral Project.
At @washingtonpost you can find a job If you write us and you're a good commenter, write well, have something to say. We'll find you #ijf16
— Anna Ghezzi (@anna_ghezzi) April 8, 2016
Al WP il lettore è incoraggiato a partecipare, ma il giornalista non resta a guardare, osserva e si coinvolge, tanto che i migliori commenti diventano spunto per assumere futuri giornalisti.
Atteggiamenti che aiutano a fare il passaggio da “engagement” (voglio i lettori sul mio sito) a “community”: sono l’ascolto, la possibilità di mettere in discussione scelte editoriali, il senso del servizio da offrire al lettore al di là un prodotto da consumare (testo, video, foto, tweet, newsletter…).
1️⃣"Niente su di noi senza di noi"
2️⃣"Non si può fare engagement senza ascolto"
3️⃣"L'engagement alimenta engagement"@andrewhaeg a #ijf16— David Mammano (@mammanodavid) April 8, 2016
Alan Rusbridger, l’ex direttore del Guardian, l’aveva tradotto con il termine #openjournalism.
1. It encourages participation. It invites and/or allows a response #openjournalism
— alan rusbridger (@arusbridger) March 27, 2012
Oggi il Guardian prosegue su quella strada con il programma Guardian Witness ma fa ancora un passaggio successivo, che va oltre lo sfruttare i contributi dei lettori per migliorare i propri contenuti ed è quello che vede il giornalismo come strumento per aiutare i cittadini a far sentire la propria voce, ad attivarsi.
Ne ha parlato Mary Hamilton, executive editor dell’audience del Guardian, con l’esempio del progetto The Counted: “La community l’abbiamo creata su Facebook, con un gruppo, perché volevamo riunire le persone attorno a un tema e volevamo dare la possibilità di farle interagire nel modo più naturale possibile, senza l’interferenza della testata”.
Quando una comunità è virtuosa, contribuisce con spunti interessanti e fa crescere il dibattito pubblico, non c’è dubbio che questa possa venir accettata da giornalisti ed editori per il suo valore. Ma quando non è così? “Non pensare alla community che vorresti ma a quella che hai ”, dice Mathew Ingram: “Non è cosa fa la community, ma come tu interagisci con lei”.
“A volte al Guardian apriamo spazi di dibattito su un tema e i lettori cominciano a parlare di altro”, ammette Hamilton. “Invece di lamentarci dovremmo ascoltarli e capire perché il dibattito si sposta”.
Secondo Federico Badaloni, che di mestiere fa l’architetto delle informazioni, il dibattito costruttivo deve avvenire dentro luoghi disegnati per tale scopo:
Il frame costruito da @fedebadaloni per ragionare su "giornalismo costruttivo" #ijf16 ⬇ pic.twitter.com/V17bcvHJU5
— Donata Columbro (@dontyna) April 9, 2016
Badaloni ha riassunto il suo intervento sul suo blog spiegando bene i tre punti fondamentali per chi vuole avvicinarsi al giornalismo costruttivo: 1. ricerca 2. fare delle scelte 3. costruire i luoghi.
Il problema di questo approccio è che non esiste ancora un modo per misurare l’efficacia delle nostre azioni in questo senso, lo ammette anche Andrew DeVigal, che sul rapporto tra community ed engagement ha disegnato un diagramma da tenere in considerazione quando si prova a lavorarci dentro una redazione (ma anche dentro un’organizzazione non profit, perché no):
The Community + Journalism Venn Diagram from our #IJF16 "Engagement is journalism" session » pic.twitter.com/TW4QvNfmMx
— Andrew DeVigal (@drewvigal) April 8, 2016
Un esempio positivo in questo ambito è il lavoro del Guardian sull’analisi di 70 milioni di commenti sul suo sito web, dal 2006, realizzato per verificare lo stato del rapporto tra lettori e giornale, ma soprattutto con i giornalisti.
Siamo sempre stati media centric, dobbiamo diventare community centric.
Lo aveva detto Jeff Jarvis durante la sua keynote speech a Perugia nel 2015. Un anno dopo, finalmente, stiamo parlando di come farlo.
[Immagine di copertina: Ryan McGuire]